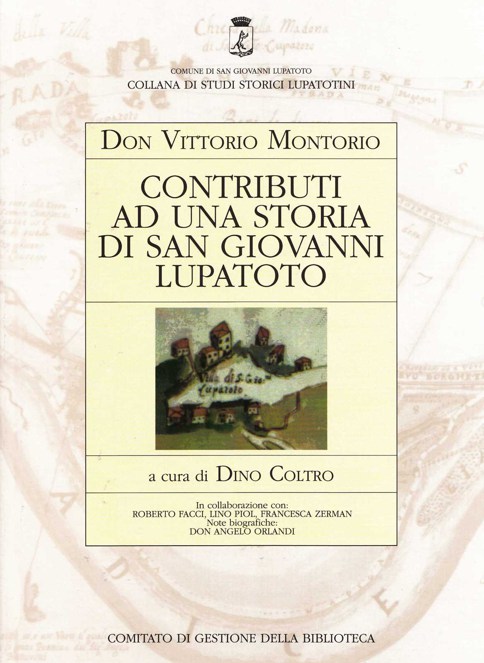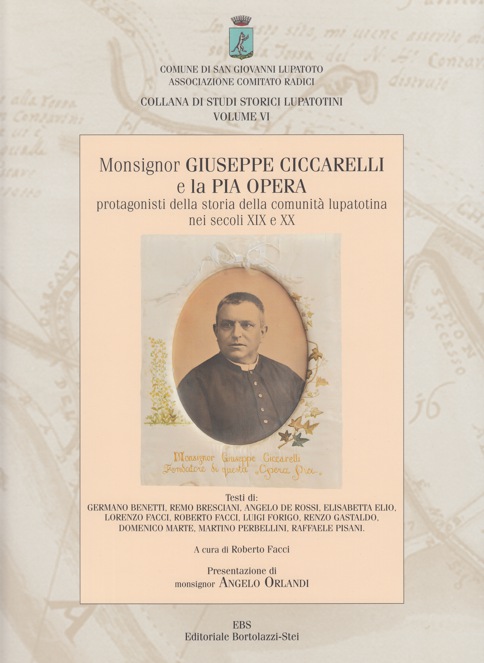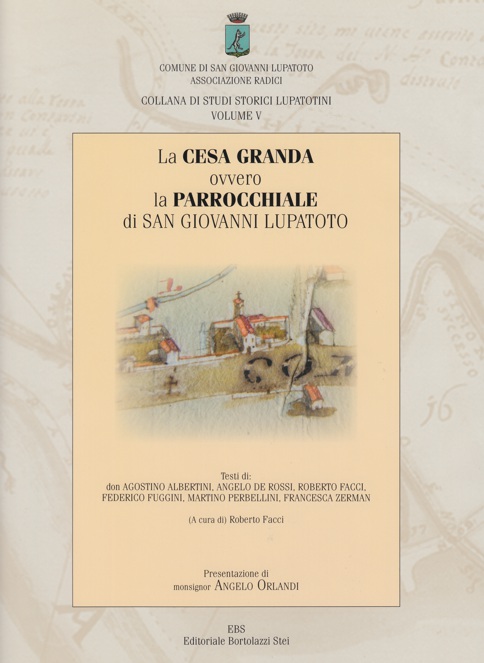Testimonianze:
23 aprile 1945, minati i ponti di Verona Testimonianza di Martino Perbellini.
(intervista del 20 novembre 2014 in via Divisione Alpina Tridentina)
Martino Perbellini è un lupatotino nato in via Verdi (Filanda), figlio di Angelo e Amalia Veronesi.
Nel 1932 inizia a frequentare la scuola materna appena attivata dal parroco don Luigi Boscaini situata in uno stabile di via Garofoli adiacente a quello che qualche decennio più tardi ospiterà il cinema Sociale.
Martino Perbellini dopo varie esperienze lavorative giovanili, tra cui lo stabilimento Galtarossa e l’Officina Locomotive di Porta Vescovo delle Ferrovie dello Stato, nel 1951 diventa geometra e nel 1980 si laurea in architettura con il massimo dei voti. Fra la fine degli anni Cinquanta e i primi Anni Sessanta è anche assessore della giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Vicenzi.
L’aviatore poi diventato Figlio della Lupa

Racconta Martino:
“L’inizio degli anni Trenta fu in Italia il periodo del fascismo delle imprese di Italo Balbo, enfatizzate in maniera propagandistica dal regime”.
Il 12 settembre 1929, a soli trentatré anni, infatti Italo Balbo fu nominato ministro dell'Aeronautica ed ideò la trasvolata dell’Atlantico meridionale con dodici apparecchi idrovolanti. Gli idrovolanti, uno dei quali guidato personalmente da Balbo, partirono per la crociera il 17 dicembre 1930 e raggiunsero Rio de Janeiro nel gennaio 1931. Dall’1 luglio al 12 agosto del 1933 Balbo guidò poi la trasvolata di venticinque idrovolanti verso il Canada. Insomma era un grande personaggio fascista e quadrumviro.
“Il regime propagandava e sosteneva con forza queste imprese. Nelle scuole si organizzavano recite che riproponevano gesta dell’aviatore. Anche nel nostro asilo, quello di via Garofoli, da poco aperto per iniziativa del parroco monsignor Luigi Boscaini, fu organizzata una rappresentazione ed io, che avevo le phisique du role perché alto e biondo, fui a mia insaputa scelto per interpretare il ruolo dell’aviatore. Suor Gertrude, la nostra maestra, mi mise insieme con altri tre o quattro bambini, tra cui Anna Albiero, a celebrare le gesta dell’eroe dell’aria. Di quella scolaresca, classe 1927, esiste una fotografia. E’ bene precisare che in quell’incarico sostituii l’amico Gastone Moschin, concittadino e famoso attore cinematografico”.
Martino conclude la scuola materna e si sposta nella scuola elementare della Madonnina.
“Frequentai le classi prima e seconda elementare alle scuole della Madonnina ed ebbi come insegnante la maestra Beatrice Cametti, che arrivava tutti i giorni in bicicletta da Verona, dove risiedeva. Per frequentare le restanti classi delle scuole elementari mi spostai alla scuola Pindemonte, chiamata anche scuola del Centro. Qui trovai come maestro Valentino Perdonà, di Raldon, che poi divenne deputato al Parlamento. Perdonà era fresco di diploma magistrale e a Raldon la sua famiglia gestiva in piazza, vicino al dopolavoro fascista, una cantina con mescita di vino. Suo fratello Gaetano era il numero due della gerarchia del partito fascista lupatotino, dopo il segretario del fascio Antonio Frigo. Come tutti i Perdonà anch’egli era un gerarca non violento e rispettoso della gente. Mi ricordo che un inverno, forse nel 1937, venni colpito da una bronchite e fui impossibilitato a recarmi all’adunata fascista che ogni sabato si teneva al campo sportivo. Lui venne a trovarmi a casa mia e mi portò un po’di caramelle. Noi Balilla lupatotini andammo in bicicletta a trovarlo nel 1940 a Castelletto di Brenzone, nell’ospedale gestito dalla suore, dove lui era ricoverato per una malattia polmonare che poi lo portò prematuramente alla morte. Al funerale, noi seguimmo il feretro vestiti da Balilla”.
Da Figlio della Lupa a Balilla

Martino Perbellini quando comincia a frequentare la scuola diventa subito Figlio della Lupa. Quella dei Figli della Lupa era un’organizzazione ideata nel periodo fascista dall’Opera nazionale Balilla. Balilla si diventava, invece, a 9 anni.
“Vestivamo con una camicia di cotone nero con cinturone grigio e bretelle bianche e, in testa, avevamo un fez nero in lana” ricorda Martino. “Al sabato alle 14 dovevamo essere puntuali alle adunate al campo sportivo. Facevamo le esercitazioni con un fucile di legno prodotto dalla falegnameria Albiero adiacente alla Vetreria. Un po’ eravamo obbligati ad essere presenti e un po’ ci divertivamo! Gaetano Perdonà era il nostro capo”.
Il sabato fascista era un appuntamento da non perdere. Al sabato si andava a scuola in divisa e la pomeriggio si tenevano le adunate e i corsi di premilitare.
Erano gli anni delle sanzioni economiche nei riguardi dell’Italia (dicembre 1935), dell’autarchia e degli orti di guerra. “I giardini sottostanti alla vecchia torre erano coltivati a grano e c’era una grande vanesa de formento anche fra il viale alberato e la strada”.
Da Galtarossa alle Ferrovie

Nel novembre 1941 a 14 anni, dopo aver frequentato le scuole di avviamento industriale alle “Galileo Ferraris”, Martino viene assunto alle Officine Galtarossa come operaio apprendista fabbro.
“Mi pagavano 0,64 lire l’ora ed alla sera dalle 20 alle 22 frequentavo un corso serale per diventare tornitore”.
L’Italia è in guerra e, quando si verificavano attacchi aerei, gli operai abbandonano il posto di lavoro e vanno a cercare protezione nei rifugi.
“Io inforcavo la bicicletta, che avevo appena fuori del capannone dove si lavorava, e salivo fino in Valdonega. In via Marsala, c’erano infatti alcune grotte nella collina che ospitavano molta gente durante le incursioni dei bombardieri”.
Nel 1944 il padre di Martino si ammala e, mancando il suo contributo, occorre assicurare altre entrate finanziarie in casa.
“Sentii che cercavano operai tornitori in Ferrovia, alla Officina Locomotive di Porta Vescovo, ma per cambiare posto di lavoro occorreva il benestare della Prefettura” racconta Martino. “Così, nel maggio 1944, mi recai in Prefettura a Verona dove ad un funzionario presentai il mio caso e la necessità di cambiare lavoro in fretta. Il funzionario comprese subito le mie esigenze, in pochi minuti mi fece avere il permesso e io potei cambiare posto di lavoro andando alle Officine di Porta Vescovo, dove tuttavia il pericolo di incursioni aeree era maggiore”.
“Molte decine di anni dopo, precisamente 67 anni dopo, ad un incontro organizzato dall’associazione culturale Il Salice incontrai il prefetto di Verona Wilfrido Zafarana e gli raccontai la mia esperienza del tempo di guerra con la Prefettura. Lui si rivolse alla moglie e disse: “Questo racconto è realmente accaduto. E’ tutto vero”. Quel funzionario che mi aveva ricevuto in Prefettura e dato il via libera al nuovo posto di lavoro… ce l’avevo davanti. Era il prefetto Zafarana, reduce della campagna di Russia, spentosi nel dicembre 2012 all’età di 99 anni”.
Il posto di lavoro alla Officina Locomotive era molto ambito, perché assicurava un reddito abbastanza alto e certo, con il quale si poteva programmare il futuro.
23 aprile 1945: i ponti di Verona minati

Racconta Martino Perbellini che come riporta il libro “Eravamo ribelli” (curato da Maurizio Zangarini per Cierre Edizioni) gli uffici amministrativi dell’Officina erano stati trasferiti alla Biondella. Il 22 e il 23 aprile 1945, nei giorni precedenti all’arrivo degli Americani, gli operai vennero convocati lì per essere liquidati dello stipendio e della mensilità in deposito, prima della ritirata tedesca.
“Partimmo intorno alle 8.30 del 23 aprile 1945 da San Giovanni Lupatoto in un gruppo di lavoratori delle Ferrovie per ritirare la “paghetta”. Tra gli altri erano presenti Silvano Mozzo, Edoardo Veronese ed Edgardo Prati. Passando sul traghetto di Porto San Pangrazio, raggiungemmo gli uffici siti nella zona di via Cipolla dove ci consegnarono ad ognuno circa 4mila lire”.
“Per il ritorno scegliemmo di passare per via XX Settembre, stradone San Fermo e Basso Acquar.
Quando arrivammo nelle vicinanze del Ponte delle Navi fummo fermati da un soldato tedesco di guardia che ci fece capire che, se avessimo voluto passare, avremmo dovuto spingere fino a metà ponte un carrello che si trovava lì vicino sopra il quale erano sistemati diversi pacchi. Accettammo un po’ a malincuore quella fatica e, pur di transitare sul ponte, spingemmo il carrello. Soltanto mentre lo spingevamo ci accorgemmo che nelle scatole posizionate sul carrello c’era esplosivo. Arrivammo con il carrello sul luogo indicatoci e ci allontanammo in tutta fretta. L’esplosivo fu poi posizionato nella camere di scoppio sotto al ponte”.
Va ricordato che i comandi germanici, il 25 aprile mattina, si erano impegnati con il vescovo di Verona, se la popolazione si fosse astenuta da qualsiasi atto di ostilità, a non far saltare i ponti e a tenere la zona centrale della città esente da combattimenti.
Alle 18 i tedeschi, infrangendo il patto, fecero saltare il ponte della ferrovia e, a seguire, tutti gli altri ponti.
Prosegue Martino: “Nel 1951 ho cominciato a fare il geometra e per i collaudi mi affidavo all’ingegner Giuseppe Benini che era in contatto con un tecnico del Genio Civile di nome Aldo Verzè. Questo tecnico negli ultimi giorni della guerra era vicecomandante della caserma di Montorio, comandata dal famoso colonnello Alfonso Amerio. Questo ufficiale mi confermò che anche nella cerchia dei militari circolava con insistenza la voce che esisteva il patto per non far saltare i ponti, patto che poi i tedeschi infransero”.
Il segretario del fascio Antonio Frigo

Ricostruisce Martino Perbellini: “Il dottor Frigo, per quanto mi riguarda, sebbene fosse un gerarca, era una persona corretta e giusta e parecchi di coloro che furono assunti in Cartiera lo devono a lui. Di professione faceva l’impiegato di banca presso la Banca Popolare di Verona. Noi Balilla, di tanto in tanto, lo vedevamo nel suo ufficio all’interno di palazzo Campagnola. Chi come me, fra il 1938 e il 1941, frequentava le scuole di avviamento industriale in città, si trovò anche ad aiutarlo.
Il regime stampava infatti il periodico “Il Martello” che veniva consegnato in un ufficio fascista dietro a piazza Brà e da lì doveva essere inviato per posta, munito di francobollo, agli abbonati. Noi, finito l’orario scolastico, dovevamo recarci al bar Mastino dove Frigo ci aspettava, poiché avevamo il compito di applicare i francobolli sul giornale. Lui, ogni volta, ci offriva un aperitivo chiamato “Americano”.
La sede del fascio a San Giovanni Lupatoto, dove il segretario Frigo aveva l’ufficio locale, era nel palazzo del municipio.
“La porta di entrata era, guardando il palazzo dalla piazza della chiesa, quella più a sinistra del piano terra. La prima stanza era spoglia. C’era soltanto una radio, che noi ascoltavamo quando venivano trasmessi i discorsi del duce. C’era anche una macchina per scrivere, dove molti di noi si esercitavano a battere i tasti. Nella stanza successiva c’era l’armeria e dietro ancora c’era l’ufficio di Frigo, davanti al quale ogni giorno si formava una fila di cittadini questuanti”.
“Mi sento di dire che Frigo era una persona corretta perché non ha usato la sua posizione per le sue fortune personali” continua Martino. “Alla fine della guerra è andato a lavorare a Parma, nella ditta di prodotti farmaceutici del fratello Alfonso”.
Il direttore della cartiera Saifecs Guglielmetti faceva parte del giro dei gerarchi del fascismo lupatotino ma i suoi compiti erano soprattutto di coordinamento amministrativo.
La ritirata del tedeschi

Ecco la testimonianza di Martino Perbellini riguardo alla situazione del paese di San Giovanni Lupatoto all’arrivo delle truppe americane:
“Negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale io abitavo con la mia famiglia in via Porto, circa all’altezza dell’incrocio con via Paquara. Dal 23 al 25 aprile sulla via c’era un transito continuo di truppe tedesche in ritirata che risalivano la strada in direzione dell’Adige. Ad assicurare l’attraversamento del fiume non c’erano soltanto i barconi del Porto ma anche un fuoribordo tedesco che faceva la spola continuamente tra le due rive. Il giorno di arrivo degli Americani in paese, non c’era più nessun tedesco né in paese né di passaggio su via Porto. In riva al fiume venne abbandonata un moltitudine di armi e altre dotazioni militari che nei giorni successivi venne razziata dalla cittadinanza lupatotina”.
Renzo Gastaldo
* *
*
20 maggio 1945, scoppia il Lazzaretto
“Io c'ero”, testimonianza di Sferino Bottacini.
(intervista del 5 novembre 2014 in via Brodolini)
Sferino Bottacini è un lupatotino nato in via Porto 103, nelle case del Cotonificio, il 24 marzo 1927. Suo padre Giacomo lavorava come assistente ai Cotoni (Cotonificio Manifattura Festi e Rasini), in Sala “Sotterranea”, e per questo aveva diritto all’abitazione di proprietà aziendale.
Sferino da ragazzo frequenta le scuole elementari alla Madonnina (la prima e la seconda) e alle “Ippolito Pindemonte” anche dette “del Centro”, e poi le scuole di avviamento professionale per meccanici e falegnami “Paolo Caliari” a Verona.
A 14 anni da poco compiuti, il 22 settembre 1941, viene avviato al lavoro nella cartiera Saifecs.
La bomba e il tronco

I ricordi di Sferino della Seconda Guerra mondiale, dall’osservatorio un po’ defilato di San Giovanni Lupatoto, sono vividi, in particolare per l’episodio dell’8 marzo 1945 della bomba caduta in via Porto nella segheria di Giuseppe Fieramonte, detto Biondin.
“Io lavoravo in cartiera e ogni 10-15 giorni eravamo costretti a fare i conti con gli allarmi aerei” racconta Sferino. “Quando suonava la sirena dell’allarme, abbandonavamo tutti la fabbrica per andare a ripararci nei rifugi antiaerei. Io di solito tornavo a casa. Il rifugio costruito da Biondin (Fieramonte, che gestiva una segheria con laboratorio per le “gabiette” in via Porto, ndr), distante soltanto 200 metri da casa mia, era considerato sicuro per le sue caratteristiche costruttive e perché aveva dei tronchi di pianta come copertura. L’8 marzo pare che un bombardiere alleato, colpito dalla contraerea mentre faceva un’incursione sulla stazione di Porta Vescovo, abbia deciso di liberarsi delle bombe. Una la lasciò cadere sopra San Giovanni Lupatoto. Il rifugio aveva un’entrata a forma di L, così costruita per evitare il contatto diretto con l’esterno. Tre ragazzi che lavoravano nella segheria e che erano ospiti del rifugio, Romano Ballan e Luigi Perbellini di San Giovanni, e un certo Burati di Raldon, volevano vedere gli aerei in transito sopra di loro ed uscirono. Furono coinvolti dallo scoppio della bomba e morirono”.
“La bomba fece saltare in alto anche i tronchi che sbalzarono in tutte le direzioni, fra cui verso Pontoncello ma anche verso il paese. Uno di questi tronchi atterrò dietro casa mia, dove tra i due palazzi c’era un lavatoio coperto, sorretto da quattro pilastri, e degli orti nella zona retrostante. Il tronco cadde con grande fragore, tanto che tutti pensarono ad una bomba. Intervenne un pattuglia delle Brigate Nere, che senza neppure avvicinarsi, per il temuto pericolo di scoppio, ordinò lo sgombero a tutte le famiglie del palazzo. Soltanto dopo due giorni un proprietario che si avventurò fra il lavatoio e l’orto scoprì che a cadere non era stata una bomba ma un tronco del rifugio di Biondin”.
Il 26 e il 27 aprile 1945

“Via Porto, negli ultimi giorni di guerra e in particolare il 25 e 26 aprile, era la principale via di passaggio dei Tedeschi in ritirata. Alcuni soldati in bicicletta si erano fermati anche a casa mia per gonfiare le camere d’aria delle ruote delle loro biciclette. Mio padre era andato in riva all’Adige per vedere se si poteva recuperare qualcosa tra il materiale abbandonato dai Tedeschi. Mi aveva detto che il Porto era stato fatto saltare. In quei giorni ognuno cercava di arraffare quanto poteva. Vennero depredati dai cittadini il magazzino militare del cinema Sociale, dove c’era un deposito di tabacchi, e quello del Comotto, da dove molti portano a casa quintali di verdura liofilizzata. Mio padre tornò a casa con un sacco di zucchero di canna. Un mio zio, non so come, portò a casa un cavallo e tre pecore”.
“Il 27 aprile anch’io andai in riva all’Adige in cerca di qualcosa e vidi, a bordo di un camion germanico abbandonato, un grosso pneumatico nuovo. Pensai che dallo stesso si sarebbero potuti ricavare chissà quanti copertoni di bicicletta, di cui c’era estremo bisogno, sia a casa mia sia in tutte le famiglie lupatotine. Mentre salivo sul camion per prendere lo pneumatico, vidi scappare giù un maialino. Lo rincorsi immediatamente per acciuffarlo e portalo a casa ma non riuscivo a bloccarlo. Mi vide una donna che abitava a vicino a casa mia, la Assunta Mondini detta “Carpi”, alla quale chiesi aiuto. In due riuscimmo a immobilizzare il maialino e, trovata una barella abbandonata, lo portammo a casa mia con il patto che una volta cresciuto avremmo fatto a metà”.
“Dopo qualche giorno, mentre alimentavamo l’animale con quanto disponevamo, pregustando già il momento dei salami, ci trovammo sulla porta di casa una squadra di partigiani, tutti partigiani “del giorno dopo”, che ci dissero: “Sappiamo che avete trovato un maialino, siccome era una preda di guerra tedesca, appartiene di diritto a chi è subentrato come autorità costituita. Tenetelo qui, che passeremo a prenderlo”.
“Dopo alcuni giorni senza che alcuno si facesse vivo, il maialino fu colpito dal “mal del rossin”, una malattia infettiva tipica dei suini. Chiamammo anche un veterinario che ne decretò la morte e ne ordinò il seppellimento. In pochi giorni l’animale morì. Così restammo senza maiale sia noi che i partigiani”.
I Tedeschi in fuga a Pozzo

Il 27 aprile Sferino viene mandato dal padre a vedere come sta la sorella sposata che abita con il marito in località Novarine in territorio di Zevio (luogo dove ora sorge lo stabilimento Ici Caldaie).
“Stavo pedalando quando, davanti alla chiesa di Pozzo, incrocio un mio coetaneo, un tale Tognella, che aveva in spalla il fucile. Gli chiedo: “Cosa fai con il fucile?”. “Per difesa”, mi risponde. Insieme ci avviamo in direzione di Campagnola di Zevio. Superiamo il bivio del capitello. La strada è fiancheggiata dalla campagna. Vediamo avvicinarsi da lontano un camion militare. “Mi sembra americano” dice il mio compagno. Io mi accorsi invece che era tedesco, carico di soldati, e vidi, mentre si avvicinava sempre più, che stavano addirittura puntando le armi contro di noi. “I ne tira!” dissi a Tognella e ci buttammo nella sesa (siepe). Il camion ci superò in tutta velocità, probabilmente ben più concentrato sul fatto di sfuggire agli Americani che non preoccupato di noi. Poi ci dissero che una jeep americana lo aveva intercettato a Pozzo, centrandolo con un colpo di cannoncino, e che i Tedeschi in fuga furono infine fermati e uccisi all’osteria La Palma di via Legnago a Verona. Io, nei giorni successivi, fui alle prese con il difficile compito di levarmi le spine della siepe che mi erano rimaste conficcate nelle ginocchia”.
Il segretario del fascio Antonio Frigo
“In quegli anni c’era il fascismo e le massime autorità in paese erano il podestà, il cavalier Renzo Pasti, e il segretario politico, dottor Antonio Frigo.
Il podestà Pasti era una persona molto equilibrata e saggia.
Il dottor Frigo, laureato in economia e commercio, di mestiere era impiegato presso un banca di Verona. Di lui noi ragazzi avevamo una certa soggezione e gli portavamo un po’ di riverenza in quanto, dato il carattere energico e sbrigativo, occasionalmente poteva impartire qualche sonoro ceffone a chi non si comportava correttamente, secondo le regole di quel tempo.
Il dottor Frigo non poteva essere molto presente nella sede lupatotina del Fascio, situata al piano terra del municipio, in quanto nei giorni lavorativi svolgeva l’attività di bancario. Di certo Frigo non ha usato la sua posizione per trarne arricchimento personale.
Per le parate, noi giovani, guidati dal nostro responsabile Gaetano Perdonà, avevamo formato una squadra specializzata nelle cerimonie e rappresentazioni ufficiali. Girammo tutta la provincia e presenziammo all’adunata con il Duce Mussolini in Arena”.
Le vendette della fine della guerra

“Ricordo perfettamente che nei giorni successivi alla fine della guerra vidi attraversare il centro della piazza un piccolo corteo. Erano un gruppo di partigiani che scortavano in municipio per un processo sommario l’ingegner Gugliemetti, il direttore della cartiera Saifecs, uomo di grande competenza tecnica e professionale che aveva la colpa di aver comandato la fabbrica nel periodo fascista.
Il dirigente fu condannato e internato in un campo di prigionieri collaborazionisti funzionante nei pressi di Forte Tomba, dal quale fu tirato fuori per interessamento del sindaco Ottavio Zanetti.
Prima di essere portato al campo il dirigente fu accompagnato e trattenuto sotto alla torre dell’acquedotto. Qui gli avvicinò un lupatotino che lui aveva licenziato, gli tolse il cappello e gli diede un gran pugno in testa. Quel lavoratore era stato allontanato dal lavoro per aver dato una bottiglietta di solvente a una donna che lavorava con lui. La donna era stata scoperta nel corso dell’ispezione casuale in portineria all’uscita della Cartiera. Guglielmetti li aveva licenziati entrambi ma il lavoratore voleva vendicarsi”.
I copertoni
I copertoni per la sua bicicletta (il padre Giacomo, per incrementare il magro bilancio familiare, si applicava nella riparazione delle bici di amici e parenti) Sferino riuscì comunque ad averli. Prima glieli costruì il padre, poi arrivarono dal datore di lavoro.
“Mio padre recuperò ai Cotoni dei tubi di gomma scartati e ripiegandoli alla bisogna, legandoli poi con il filo di ferro, riuscì a ricavare dei copertoni pieni per la mia bici. La giuntura mi costringeva a un sobbalzo ad ogni giro di ruota ma mi accontentai”.
Poi ci fu il salto di qualità. “La Saifecs aveva rapporti con la Pirelli, per la quale lavorava come fornitore. La fabbrica lombarda consegnava un certo numero di pneumatici ai clienti e così, ogni mese, due lavoratori, a rotazione, poterono ottenere i copertoni”.
20 maggio 1945: scoppia il Lazzaretto

Sferino racconta.
“Era una domenica afosa e non si sapeva come tirare sera. Incontro in piazza Silvino Antonini, mio vicino di casa. Mi dice: “Vieni con me al Pestrino, vediamo se c’è qualcosa da portare a casa”.
In quei giorni, poco dopo la fine della guerra, c’era in tutti la spasmodica ricerca di accumulare beni, forse per i molti patimenti vissuti nel periodo bellico.
“Va bene, andiamo” gli rispondo. Ci avviamo in bici verso il forte Santa Caterina del Pestrino, dove pensavamo di trovare qualcosa. Davanti all’entrata c’è un Military Police che soltanto guardandoci capisce le nostre intenzioni e ci fa segno di proseguire perché lì non si può entrare. Mentre stiamo percorrendo la via per tornare a casa, vediamo un contadino su un carro trainato dal cavallo. Sul carro ci sono alcune casse di legno. “Dove le hai prese?” chiediamo. “Al Lazzaretto, là c’è un sacco di gente che porta via di tutto” ci risponde. Ci dirigiamo anche noi verso il tempietto. Quando arriviamo, vediamo almeno cento persone, in mezzo ad un tappeto di balistite, indaffarate a svuotare munizioni. C’erano molte donne, sedute o accovacciate, che stavano svuotando i sacchetti di tela bianca che, posti all’interno dei bossoli di ottone, contenevano l’esplosivo. I sacchetti venivano impiegati poi per usi domestici. Vidi un uomo che usciva da una cella con un grande bossolo in mano e si apprestava a batterlo su uno spigolo di pietra per svuotarlo della polvere da sparo. Gli chiesi se non era pericoloso, mi rispose che non c’era pericolo e che lui, per lavoro, l’aveva fatto molte volte anche in altri luoghi. “Non hai paura?” insistetti. “No, sono proiettili senza accensione” mi rispose. I bossoli di ottone vuoti venivano venduti o usati per ricavare utensili per cucina. In lontananza vidi entrare un carretto con un Bugna che conoscevo. Anche noi ci apprestammo a svuotare le munizioni. Alcuni bossoli vuoti li accatastammo in un corte agricola vicina, dopo aver chiesto il permesso al proprietario dicendogli che saremmo poi passati a prelevarli.
Dopo qualche ora di lavoro, molto stanchi, anche per il caldo soffocante di quel pomeriggio, ci sedemmo sui gradini all’esterno del tempietto posto al centro del Lazzaretto per riposarci un po’. Appena seduto vidi una fiammella. Mi colse subito l’istinto di fuggire e così facemmo. Infilammo di corsa una breccia nel muro, forse realizzata dai Tedeschi nel primo tentativo di far scoppiare il Lazzaretto, e ci mettemmo a correre a più non posso in direzione dell’Adige. Sentii alle spalle un fortissimo scoppio e un’ondata di calore alla schiena. Nella fuga io venni colpito da un mattone a una spalla. Seguirono altri due boati.
Mentre mi avvicinavo all’Adige arrivai a una siepe e vidi una strada. Sulla strada c’era un ragazzino che zoppicava. Mi fece segno che era stato colpito da una scheggia ad una gamba. Gli guardai il polpaccio e vidi un profondo taglio che raggiungeva quasi l’osso. Lo sorressi aiutandolo a correre verso la strada. Lui si lamentava per il dolore. Mentre ci allontanavamo dal Lazzaretto, vedemmo venirci incontro un’ambulanza dell’esercito statunitense, richiamata probabilmente dallo scoppio. Caricammo il ferito, che non ho mai più incontrato. Intanto ci avvolse una nube di fumo originata dallo scoppio.
Nella deflagrazione perirono ventitré persone tra le quali sei abitanti di San Giovanni Lupatoto. I due fratelli Bugna, inizialmente artigiani calderai e poi commercianti di casalinghi, la moglie del macellaio Rinaldi che aveva bottega sull’edificio d’angolo sulla destra di via IV Novembre, un certo Brivio che faceva il tecnico al Ricamificio Automatico e un Guerra, un ragazzo tredicenne residente nel palazzo “Pipi” adiacente alle scuole del Centro.
Morì forse anche un Faccini, abitante in vicolo Fogazzaro, padre del geometra Palmino, che per alcuni anni ha prestato servizio nell’ufficio tecnico del Comune.
Gianni Dalla Vedova, ex militare pontiere di stanza a San Giovanni, cognato dei Bugna, coinvolto nello scoppio, fu ferito seriamente, tanto da restare claudicante per tutto il resto della vita.
Io non tornai subito verso casa ma mi attardai un po’ nei dintorni. Il mio amico Antonini invece, che nel momento immediatamente successivo allo scoppio si era allontanato da me, si diresse subito verso San Giovanni. A Palazzina incrociò mio padre, che era stato mandato in mia ricerca da mia madre, spaventata dallo scoppio, udito anche in paese. Mio padre, dopo aver ottenuto mie notizie da Silvino, lo caricò in bicicletta e lo portò a casa mia a rassicurare mia madre. Poi riprese la strada del Lazzaretto e mi trovò davanti alla croce del Lettobòn, mentre rientravo a piedi verso San Giovanni. Ricordo che scese dalla bici e, senza dire nulla, mi avvolse in un fortissimo abbraccio. Uno dei pochi espliciti atti di amore paterni nei miei confronti”.
Il primo vestito
Conclude Sferino:
“Dopo aver tenuti nascosti sotto il letto per alcuni mesi una ventina di bossoli di ottone, per evitare eventuali sequestri da parte dei “spartigiani” (letterale), decisi di venderli e ci riuscii realizzando la somma di 7.500 lire con la quale potei acquistare la stoffa per il mio primo vestito da adulto. Allora avevo diciannove anni. Comprai la stoffa di lana vigogna di colore grigio cenere in Cartiera. L’amministrazione dello stabilimento era infatti riuscita ad ottenere dalla ditta Marzotto di Vicenza alcuni tagli per vestito da uomo, tutti dello stesso colore, a costo molto conveniente. Il vestito mi venne confezionato su misura dal bravo sarto Alessandro Lerin, il quale aveva l’abitazione e il laboratorio in via IV Novembre, dove attualmente si trova la Residenza Ferrari della Pia Opera Ciccarelli”.
Renzo Gastaldo
* *
*
Mario Stoppato torna a casa nei giorni della Liberazione.

Mario Stoppato, 95 anni, memoria lucidissima, ci racconta in un soleggiato pomeriggio di settembre 2021, nel tinello della casa di via Porto, le sue esperienze di guerra.
Racconta Mario:
Sono nato in via Cartiera a San Giovanni Lupatoto il 26 febbraio 1926. Mio padre Ugo faceva il contadino e mia madre Maria lo aiutava. Insieme mandavano avanti la famiglia, composta anche da altri miei tre fratelli.
Ho trascorso la fanciullezza andando a scuola e dell'adolescenza mi ricordo i sabati pomeriggio passati al campo sportivo con la divisa da avanguardista a fare gli esercizi ginnici.
A quattordici anni fui assunto come operaio in Cartiera, ai tempi in cui il direttore era il signor Guglielmetti (l'ingegner Gino Hintermann era socio amministratore).
Il ricatto
Nel giugno 1944 chiamarono alla leva i primi tre mesi della classe 1926. In previsione di ciò e tenuto conto dell'aria che tirava (si sentiva sempre più spesso, tra il popolino, parlare di imminente arrivo degli Alleati e di fine della guerra), per evitare di finire sotto le armi, io mi ero allontanato da casa e nascosto in una campagna della Bassa veronese di proprietà di conoscenti.
Dopo pochi giorni che ero via da casa, mi raggiunse nel nascondiglio mio fratello Bruno e mi disse: “I fascisti sono venuti a casa nostra in cerca di te, per portarti sotto naja in Germania. Abbiamo detto che non sapevamo dove eri. Ci hanno risposto che se non tornavi subito e ti presentavi in caserma, avrebbero portato via nostro padre e l'avrebbero spedito a lavorare in Germania”.
Non avevo scelta. Mi rassegnai a tornare a casa e così feci il giorno stesso.
Arrivato sconsolato a casa, trovai mio padre e mia madre che cercavano di rincuorarmi. Mi dissero che per evitarmi il fronte o il lavoro in Germania avrebbero tentato di far intervenire don Carlo Stoppato, un sacerdote lupatotino, cugino di mio padre, il quale pur essendo un prete “poco in linea” con il regime, sarebbe riuscito a trovare una soluzione per sottrarmi alla partenza per la Germania.
Don Carlo è un sacerdote che fra il 1944 e il 1945 collaborò con gli Alleati inviando notizie via radio (era un appassionato di apparecchi radiofonici e ricetrasmittenti), attività che gli procurò un arresto e conseguenti torture da parte dei fascisti. Negli anni seguenti ricevette varie onorificenze e decorazioni per questa attività ed inoltre il Comune di San Giovanni Lupatoto gli ha intitolato una via nell'area dell'ex cotonificio MFR.
Soldato della Repubblica di Salò
Venni trasportato alla caserma di Montorio dove mi dotarono di vestiario militare e mi inquadrarono nel reparto che doveva partire per la Germania. Il giorno dopo ci schierarono tutti noi destinati al Fuhrer nel cortile della caserma in attesa della partenza.
Io ero sulle spine in quanto speravo che qualcuno mi richiamasse comunicandomi una diversa destinazione. Ad un certo punto, quando ormai temevo il peggio, entr ò nel cortile un motociclista portaordini che salì negli uffici del comando. Poco dopo scese un caporale che chiamò cinque nomi, tra i quali il mio, ci fece uscire dalle righe e ci disse di presentarci in questura il giorno dopo. Mi arruolarono come agente di polizia ausiliario e per addestramento fui mandato alla caserma di Montorio. Dopo alcuni mesi fui destinato, anziché alla Germania, a fare la guardia a ministeri della Repubblica di Salò, costituita dal Duce nel settembre del 1943 sulla riva sinistra del lago di Garda.
Io e due altri compaesani, Elio Bendazzoli e Sergio Caprara, venimmo assegnati al corpo di guardia del Ministero dell'Interno che si trovava a Monte Maderno, una località del comune bresciano di Toscolano Maderno.
Nonostante le notizie che giungevano sull'andamento della guerra, tra un turno di guardia e l'altro, trascorremmo alcuni mesi senza particolari problemi. Anzi, facemmo amicizia con alcuni residenti della zona, anche facoltosi, con i quali, nel tempo libero, uscivamo a cacciare sulle pendici del monte Maderno. Loro qualche volta ci prestavano i cani per stanare le lepri e i fagiani. Ricordo che abbastanza spesso tornavamo in caserma con le prede di caccia. Io andavo a cacciare con il mio fucile, che mi ero portato da casa al rientro da un breve permesso.
Al posto di guardia esterno, arrivammo anche a fraternizzare con alcuni partigiani.
Il 24 aprile 1945 e la traversata
Le notizie di “Radio Scarpa” ci dicevano che il fronte stava, giorno dopo giorno, salendo e che oramai gli Americani e gli Inglesi stavano arrivando al fiume Po. Si commentava dicendo che la disfatta era praticamene in atto e che era il momento di mollare tutto e di andare a casa. Arrivò in bicicletta anche mio fratello Bruno che mi recò una lettera di nostra madre con la quale la stessa chiedeva di rientrare in paese con la massima urgenza per suoi gravi problemi di salute.
Chiedemmo notizie su cosa fare, intorno al 20 aprile 1945, ad un tenente del nostro reparto. “Io non vi posso dare indicazioni su come comportarvi, ma se scappate vi consiglio di non farlo attraverso le strade normali, che pullulano di posti di blocco della Milizia e di quelli delle truppe tedesche”.
Sentite queste parole ci chiedemmo per quale via e con che mezzo tornare a casa. A un milite veneziano che era con noi, Bruno Deste di Murano, venne in mente di rubare un motoscafo, mezzo che lui sapeva pilotare, in dotazione alla guardia adibita agli spostamenti di Claretta Petacci, che dimorava a Gargnano. Con il motoscafo avremmo dovuto attraversare il lago e raggiungere la riva veronese per poi prendere la strada di casa.
Il veneziano alla sera del 23 aprile fece un veloce sopralluogo al porticciolo dove era ormeggiato il mezzo e tornò con una ferale notizia: il motoscafo c'era ma era completamente senza carburante.
Ci guardammo tutti in faccia, io, mio fratello, il veneziano e due altri soldati di Caprino, Giancarlo Campagnari e un tal Rocco che noi soprannominammo “Nereo”, che si erano uniti a noi nel progetto di fuga.
“Se non c'è disponibile il motoscafo, andremo con una barca a remi e partiremo stasera stessa” decise il veneziano e tutti concordarono. Affidai il mio fucile da caccia e la bicicletta di mio fratello ad una famiglia del luogo (le andai a riprendere dopo la fine della guerra).
Ci acquattammo in riva al lago nascondendoci fra gli oleandri fino alle 10 di sera quando cominciava a fare buio e vedemmo comparire il veneziano a bordo della barca a remi. Salimmo a bordo in sei: i due soldati di Caprino, Bendazzoli, mio fratello ed io, in aggiunta al veneziano.
Io e Bendazzoli ci mettemmo ai remi e cominciammo a remare mentre il veneziano puntava la prua della barca verso est, in direzione della sponda veronese del lago. Il lago era di una piattezza unica e non si vedevano onde. Circa a metà percorso però ci trovammo però avvolti un denso ed esteso banco di nebbia senza aver più come riferimento la riva veronese del lago.
Vagammo un po' nella nebbia mentre il veneziano ci rassicurava che la situazione era sotto il suo pieno controllo. Ci raccomandò anche di non fumare per evitare di essere individuati da “Pippo”, l'aereo alleato che turbava le notti dell'Italia del nord.
Versa le 4 del mattino, dopo circa 6 ore di traversata, arrivammo nei pressi della località di San Vigilio, tra Torri del Benaco e Garda, dove scendemmo a terra abbandonando la barca.
I commilitoni di Caprino dissero che loro conoscevano bene le strade secondarie che dal lago salivano a Costermano ed Affi. Qui salutammo i due di Caprino che si incamminarono per il loro paese. Noi per puntare su Verona, ben consci della assoluta necessità di non passare per le vie di collegamento principali, optammo per le strade vicine al fiume Adige. Prima di arrivare a Bussolengo, ci imbattemmo in una casa di casa isolata. Entrammo nel cortile e chiedemmo se avessero da darci qualcosa da mangiare. Prima precisammo chi eravamo, spiegando bene, parlando in dialetto, che eravamo veronesi come loro. La diffidenza nei nostri confronti scomparve in pochi secondi e ci diedero mezzo secchio di latte appena munto accompagnato da alcuni tozzi di pane. Mangiammo in fretta, ringraziammo e ci rimettemmo in strada verso la città.
A mezzogiorno eravamo a San Vito al Mantico e poi in un'ora raggiungemmo Verona e poi San Giovanni Lupatoto. Qui, Bendazzoli ci lascio per tornarsene a casa sua. Io e il veneziano giungemmo nel tardo pomeriggio, mentre mio fratello affaticato e dolorante si attardò per strada. I miei genitori ci aspettavano sul selciato davanti a casa, si disperarono perché mio fratello non c’era ma poi, informati che Bruno era solo in ritardo, si tranquillizzarono e mio papà corse a prenderlo laddove si era fermato.
Due giorni dopo, il 26 aprile 1945, gli Alleati, arrivarono a San Giovanni Lupatoto. Il veneziano restò con noi fino alla fine della guerra e poi se ne tornò a Murano. Qualche giorno dopo, consegnai le armi avevo portato con me da Maderno al comando partigiano del comune di San Giovanni Lupatoto. A diciannove anni conclusi così la mia esperienza di guerra.
Dopo un anno passato in famiglia e dopo aver ripreso il lavoro in Cartiera, il 1° maggio 1946 fui chiamato a svolgere il servizio militare e divenni alpino. Tornai alla caserma di Montorio per il CAR e poi fui assegnato al Battaglione “Trento” del VI Alpini con sede a Merano. La naja nelle penne nere durò un anno. Da allora deposi le armi da combattimento. L'unica arma che ho imbracciato negli anni successivi e fino all'anno scorso è stato il mio fucile da caccia, per passione e per onorare la licenza che detengo da 79 anni.
Renzo Gastaldo